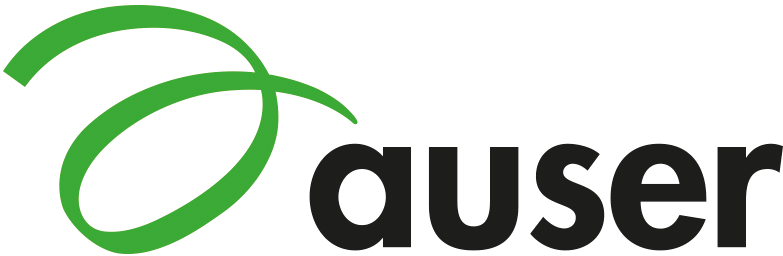Incontro culturale
Sultani, duci o influencer
Ecco di seguito la relazione dell’originale intervento per l’Università Aperta Auser di Conegliano che Bruno Longo, come sempre documentatissimo, ha dedicato a Erdogan il 14 novembre 2024, riscuotendo l’attenzione molto interessata del numeroso pubblico presente.

Un articolo del CORRIERE DELLA SERA di qualche tempo fa cominciava con la frase in grassetto: A chi appartiene il kebab, che i tedeschi chiamano Dõner? Ohibò, ho pensato, almeno tre errori in una frase di dieci parole. Kbab è una parola araba che vuol dire arrosto, i turchi dicono kebap con /e/ e la /p/ che non ci sono nell’alfabeto arabo e intendono uno spiedino di carne macinata, di solito nelle varianti Urfa (semplice) e Adana (piccante). Quello che noi chiamiamo kebab, loro (e certo anche gli almanci, i turchi di Germania, dai quali i tedeschi hanno certo preso il termine) lo chiamano dõner dal verbo dõnmek, girare. Perché metto i puntini sulle i e la faccio lunga su di una cosa in fondo così piccola? Perché se è questo il livello degli articoli nella stampa ritenuta di qualità, allora il compito di parlare di paesi fuori della porta di casa diventa proibitivo. Cambiare le parole non cambia il mondo, ma usare le parole giuste aiuta a capirlo, il mondo.

Cominciamo allora dalle parole. Cominciamo dall’appellativo più usato, SULTANO, per parlare del Presidente della Repubblica turca.Anche in Turchia l’opposizione si mobilita contro il saltanat, contro un Erdoğan accusato di riproporre l’antico modo di comandare del passato. In realtà, delle decine di titoli del capo degli Ottomani, alcuni di delirante inventiva poetica come ‘signore degli orizzonti’ (ufukların hȕnkȃrı) quasi tutti erano di derivazione iranica, con preferenza accordata a Padișah. Sultan, parola di derivazione araba, era usato ma spesso con la connotazione di capo militare. Per passare dalla nomenclatura alla sostanza, vale la pena di ricordare che il Padișah era il proprietario de jure di tutte le ricchezze del paese, di tutta la terra e che i suoi ministri erano suoi servitori. L’impero era quindi l’impero dei discendenti di Osman il capostipite della dinastia, gli Osmanli, i nostri Ottomani. Un esempio moderno potrebbe essere l’Arabia Saudita, che è appunto l’Arabia che appartiene ai discendenti di Suud, il capostipite settecentesco di Mohammed bin Salman.
Erdoğan è certamente diventato un uomo molto ricco e molto ricchi sono diventati i suoi famigliari e i suoi sodali. Ma la ricchezza del paese NON gli appartiene de jure.

Anche se, anche se: Erdoğansi trova al comando del Tȕrkiye Varlık Fonu, un fondo di investimento privato istituito nelle more del fallito colpo di stato del 2016 che comprende la Ziraat Bankası, la Halk Bank e la Vakıf Bank, le poste, la Turkish Airlines, i porti, la Borsa di Istanbul eccetera eccetera e amministra un portafoglio di 100 miliardi di dollari. E attenzione: la posizione è indipendente da quella di Presidente della Repubblica. Anche se cambiasse il presidente, Erdoğan rimarrebbe alla testa del TVF. Se vogliamo affibbiargli un titolo, allora meglio sarebbe usare quello di poliarca usato da Bàlint Magyar nella sua classificazione delle società postcomuniste. Il possessore di una ricchezza che è il prodotto dell’occupazione del potere politico, una ricchezza che non deriva da mera corruzione ma è risultato e contemporaneamente agente di potere politico.
Perché dunque gli oppositori turchi, che tutte queste cose le sanno benissimo, insistono con Sultano. Un motivo c’è. Dall’epoca di Selim I, dalla conquista dell’Egitto e dell’Arabia, il Sultano era anche il HALIFE, il discendente di Maometto, il Capo dei Credenti. Ora un Halife riconosciuto non esiste più, ma Erdoğan non manca mai di assumere una posizione che lo pone alla testa dei mussulmani, preferibilmente quando si tratta di contrapporsi ai decadenti eredi dei crociati. Aggiungiamo che in Turchia esiste un Ministero della Religione con personale ben pagato dallo stato e che le prediche del venerdì sono dallo stesso redatte per essere lette, del tutto uguali, in ogni angolo del paese. Ma, attenzione, il Ministero NON l’ha inventato LUI, dalla proclamazione della Repubblica è sempre stato così. L’essere la religione dichiaratamente uno strumento dello stato, che pur in teoria permane laico, permette all’AKP, al partito di governo, di proporsi come continuatore, meglio inveratore della tradizione turca. I movimenti di popolazioni a seguito della sconfitta nella Prima guerra mondiale che sancì la fine dell’Impero e la nascita della Repubblica di Atatürk, non sono stati forse organizzati sul principio della religione?

Con il bel paradosso, almeno per noi, di rifiutare parlanti della lingua non musulmani ed accettare mussulmani che del turco non sapevano neanche una parola? Spaventati? Calmi. Una cosa simile non potrebbe succedere nei nostri paesi, che sono praticamente tutti nati dalla lotta con il papato e con una cultura che è la figlia, involontaria forse, dei movimenti ecclesiali. Va anche aggiunto che non solo l’organizzazione, anche il contenuto religioso è nelle due religioni differente. Non c’è una conquista delle anime da portare avanti nell’Islam. L’accento è sul comportamento esterno, pubblico. Quello sì, deve essere assolutamente conforme. E così, tanto per portare degli esempi chiari, una manifestazione LBGTQ viene vietata e, per impedire la Parata dell’Orgoglio, ogni anno il centro città viene posto sotto sequestro con barriere e migliaia di poliziotti. Poi ti capita di arrivare tardi con l’aereo e a notte fonda scopri che sulla strada principale, vicino a casa tua, manda luci fosforescenti e musica a tutto volume un enorme club gay con clamorosi clienti di svariate nazionalità che stazionano sul marciapiede. È vero, tuttavia, che pecunia non olet, massima riverita in Turchia in questi tempi di grama vita.

ALLORA LO CHIAMIAMO DUCE? Il duce si suppone che voglia condurti da qualche parte, ma in questa accezione generale tutti i capi politici sono duci. Se tralasciamo la connotazione di nostalgia per il passato che la parola ha in certi attempati giovanotti nostrani e guardiamo alla sostanza dei fenomeni del primo Novecento, siamo costretti ad assumere che i duci e i führer volessero essere i mallevadori di una nuova umanità. Poi magari si impossessavano di paccottiglia romana o nibelungica, e però questo non li riduceva a nostalgici, se non vogliamo dimenticare le ascendenze futuristiche degli uni e il superomismo degli altri. NON C’È NIENTE DI TUTTO QUESTO NELLA TURCHIA DI OGGI. Il programma di Erdoğan (dichiarato a più riprese) è certo di riportare la religione al centro della vita del paese. Ultimo esempio, la proposta, avanzata subito dopo aver perso le elezioni locale, quando la necessità di rompere l’isolamento pareva urgente, di riformulare i programmi scolastici e sottoporli ad una pesante ipoteca religiosa tradizionalista. Tra parentesi, nonostante le paure dei kemalisti, la disseminazione spasmodica di moschee, gli spazi concessi alle confraternite, gli incrementi del numero degli IMAM HATIP, sorta di licei religiosi, tutte le inchieste demoscopiche sembrano indicare, anche in Turchia, un regresso della pratica religiosa, specie nelle città e tra i giovani. Se guardiamo una cartina con i risultati delle ultime elezioni, quelle per il rinnovo dei sindaci, vediamo che il partito di Erdoğan tiene nelle zone interne del paese, le più religiose.

I risultati per lui migliori vengono dalla provincia di Bayburt, dove c’è la più alta ed inverosimile concentrazione di moschee del Paese, già quello con il numero di moschee più alto del mondo. Ma quelle zone, l’interno dell’Anatolia, sono anche tra le più povere. E votano lui perché sono poveri, non perché sono religiosi, anche se sono religiosi essendo poveri. Certo, ci sono quartieri a Istanbul come per esempio Bașakșehir, dove le donne della nuova borghesia turca vanno in giro orgogliosamente velate, orgogliosamente esibendo una distanza, anche suntuaria, dal troppo prevalente mondo occidentale. Ma per molti che vivono a Yozgat, Bayburt, Sivas non c’è visibile salvezza dalla indigenza più drammatica se non agganciandosi all’uomo di panza locale, se non sperando nella piccola somma che uno stato elargisce ai malzum (gli oppressi) che sanno il loro posto.

La religione viene usata come ingrediente fondamentale del cemento principale dello stato turco: il nazionalismo. E niente rende evidente la forza dell’identificazione con lo stato come l’uso della parola șehit ‘martire’, titolo dato a qualsiasi soldato, poliziotto, impiegato, pompiere, usciere, morto, in qualsiasi maniera, durante l’orario di servizio, preferibilmente con una divisa, di qualsiasi tipo, addosso.
Arrivati a questo punto, la sensazione che il quadro del paese offerto resti astratto mi pervade. Così mi butto in una operazione grossolana ma forse necessaria: come sarebbe l’Italia se fosse come la Turchia di adesso? Bisognerebbe cambiare molti dati di partenza e fondamentalmente almeno due: primo, immaginare che la zona dell’irredentismo sudtirolese degli anni sessanta fosse continuata e fosse molto più ampia, coinvolgesse un quarto del territorio e della popolazione e fosse nella parte più povera del paese; secondo, che le nostre forze armate stazionassero oltre confine, nella parte meridionale dell’Austria e occidentale della Croazia, nonché da cinquanta anni in una parte della Corsica nominalmente indipendente di cui viene pagato anche il faraonico nuovo palazzo presidenziale. Bene adesso immaginate che ci sia una sola Camera eletta con sbarramento al 7 per cento; che la nostra Meloni abbia vinto il referendum e sia stata eletta con potere di nomina dei ministri e scioglimento della Camera e dei membri della Corte Costituzionale, nonché dei rettori di tutte le università statali; che ne abbia vinto anche un secondo e la carica di Presidente del Consiglio sia scomparsa e le sue funzione siano state assorbite dalla Presidenza della Repubblica; che sia diventata una degli uomini più ricchi del Paese e vada ad una partita della nazionale all’estero con cinque aerei che trasportano il suo corteo di una cinquantina di auto blindate; che suo cognato sia ministro ed un altro proprietario della principale industria delle armi; che i lavori pubblici siano affidati sempre a cinque famiglie imprenditoriali; che non ci siano cinquantamila poveracci in prigione, in maggioranza per traffico di droga ma duecentomila (sono più di duecentocinquantamila, in realtà, ma aggiusto per la differenza di popolazione: (85 milioni contro 60) in maggioranza per ragioni politiche; che il leader del partito largamente maggioritario nella parte ribelle sia condannato a 40 anni di prigione per aver incitato alla resistenza all’ISIS; che la RAI sia sempre e tutta ubbidiente e che le reti private appartengano a vari gruppi tutti debitori al Presidente delle loro fortune; che il tasso di sindacalizzazione sia molto basso e che il salario minimo, stabilito dal governo, riguardi più del cinquanta per cento dei lavoratori; che milioni di persone non possano sbarcare il lunario se non con bonus vari elargiti dal potere centrale o locale (a 3 milioni e mezzo di famiglie, dai 25 ai 45 euro al mese). Mi fermo. Il quadro è più chiaro?

Allora, che sia solo un influencer? Certo non nel senso che vuole vendere panettoni. E neanche simit. Nel senso che quello che acquisterete lo farete NON per la bontà del prodotto ma per il rapporto di fiducia che avrete stabilito con LUI. Non si tratta neanche tanto del tentativo, di cui si occupa il figlio Bilal con la sua TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), di costruire una egemonia culturale basata sui valori tradizionali. C’è stato un periodo, specie agli inizi, quando Erdoğan interveniva su tutto, arte e comportamenti personali inclusi. Fino ad un anno fa affermava orgogliosamente di essere in possesso di una teoria economica vincente e tutta contraria alla prassi corrente: il basso costo del denaro avrebbe sconfitto l’inflazione. Ora che l’inflazione continua a galoppare e che è stato costretto a richiamare un suo ministro delle finanze fino a poco tempo fa sbeffeggiato, della situazione economica, dei problemi quotidiani LUI non parla più. Parla solo di equilibri internazionali, di lotta al terrorismo (curdo), di normalleșme del quadro istituzionale interno, di nuova costituzione. Spalleggiato ora in questo dal suo alleato del MHP che si trova apertamente accusato di essere il mandante dell’assassinio del capo dell’organizzazione giovanile del suo stesso partito. Non so quanto di strumentale o di vero ci sia in questi alti discorsi. Lui comunque sa che, come padrone della politica estera, ha ancora un ruolo non messo in discussione da nessuno, all’interno e all’esterno. Così interviene al Parlamento riunito in sessione a porte chiuse su come fronteggiare le mire di Israele sulla regione. Sa che le tremebonde democrazie occidentali non sanno come occupare i vuoti di potere e sa che i turchi, da sempre e in tutti gli strati sociali, hanno nel sangue, ben filtrato dalla scuola e dalla tradizione, il calore del destino imperiale.

Poi arriva un attentato, alla TUSAŞ, ventimila persone che lavorano a progettare nuovi aerei e nuovi droni, in spazi ultramoderni e in teoria ultraprotetti. Incolpare il PKK e far aprire i telegiornali con la notizia di raid aerei su Irak del Nord e Siria del Nord, sono quasi un rifesso condizionato. Però, se è stata l’Organizzazione che ha voluto, a ventiquattro ore dalla proposta di Bahçeli, convocare in parlamento Őcalan, quel Bahçeli che pochi anni fa aveva mostrato nello stesso parlamento la corda con cui lo si sarebbe dovuto impiccare, che ha voluto far vedere che è con lei che bisogna trattare direttamente, se questo è vero, ne consegue che l’Organizzazione è molto più forte di quanto si ammetta, oppure lavora in, aperta o sottintesa, alleanza con settori dello stato profondo turco. E non ci sarebbe da meravigliarsi: sono numerosi gli esempi nella storia di nemici che si sostengono a vicenda, nella guerra trovando ciascuno il proprio tornaconto.